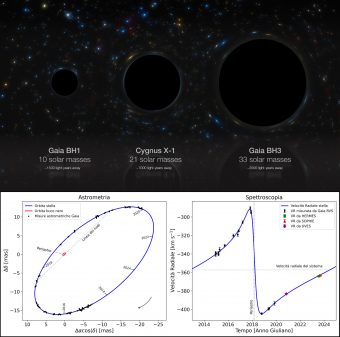I FEBBRAIO - FESTA DI FEBRUA E DI GIUNONE SOSPITA
1 Febbraio, Calende, nome da cui deriva la parola calendario: si festeggia Giunone Sospita, colei che protegge. Le calende di febbraio, ovvero l'inizio del mese che chiudeva l'anno, visto che poi a marzo iniziava l'anno nuovo. Pertanto occorreva prepararsi facendo sacrifici e purificazioni.
Tutte le calende erano dedicate a Giunone, ma nel mese di febbraio le si sacrificava un cane, invece dell'agnellina di ogni inizio mese. Il sacrificio del cane, anzi della cagna, era caratteristico della Dea Terra come divinità ctonia. La festività iniziava infatti con le onoranze rese alle tombe dei propri cari e con le invocazioni ai Lari.
Febbraio viene da: februare, cioè purificare tutto, a iniziare dall'anno passato che racchiudeva in sé, tutti i “mali” sofferti in quel periodo e che non dovevano trasferirsi all'anno successivo. Così ogni anno la necessaria purificazione si procedeva per l’anno nuovo che anticamente iniziava a marzo.
Infatti, il termine latino februarius è collegato a februa (la malattia la febbre), e si usavano panni di lana intinti nel sangue della vittima per purificare i malati, o fronde di un albero sacro con cui aspergere il sangue delle vittime sacrificali o adornare le tempie dei sacerdoti, o con focacce di farro tostato e salato, intinte nel sangue, per offrirlo agli spiriti della casa o della stalla.
Infatti, il termine latino februarius è collegato a februa (la malattia la febbre), e si usavano panni di lana intinti nel sangue della vittima per purificare i malati, o fronde di un albero sacro con cui aspergere il sangue delle vittime sacrificali o adornare le tempie dei sacerdoti, o con focacce di farro tostato e salato, intinte nel sangue, per offrirlo agli spiriti della casa o della stalla.
IUNO SOSPITA MATER REGINA
La festa venne poi soppiantata dalla festa di san Valentino, originariamente festa purificatoria di Giunone Februa, che invece venne differita al 25 giugno.
Mentre per la festa dei Lupercali, dove le antiche sacerdotesse si accoppiavano liberamente, fu usato il nome di un ipotetico vescovo di Terni,
un certo S. Valentino martire, la cui passio venne scritta all'inizio del sec. XIII dove si narra che S.Valentino, cittadino e vescovo di Terni dal 197, esercitò il suo ruolo ecclesiastico per oltre settant’anni, poi siccome lasciava perplessità la longevità del santo nonchè il martirio, spostarono il tutto alla metà del IV secolo.La festa venne poi soppiantata dalla festa di san Valentino, originariamente festa purificatoria di Giunone Februa, che invece venne differita al 25 giugno.
Mentre per la festa dei Lupercali, dove le antiche sacerdotesse si accoppiavano liberamente, fu usato il nome di un ipotetico vescovo di Terni,
Febris deriverebbe dal Dio etrusco Februus, Dio della morte e della purificazione. Nella mitologia romana la divinità avrebbe assunto il nome di Febris e sarebbe stata associata alla guarigione dalla malaria, che infestava l’agro romano e le ultime anse del Tevere.
Nelle feste, che cadevano nella seconda quindicina di gennaio, era ricordata anche la Dea Februa ovvero Iunio Februata, Giunone Purificata, e Iuno Sospita, Giunone Salvatrice.
Nelle statue e nelle monete la Dea (Giunone propizia ovvero salvatrice) viene rappresentata con una pelle di capra sul capo, una lancia in mano ed accompagnata da una serpe. La pelle di capra e il serpente le danno una connotazione di Dea Terra, colei che dà la vita, che nutre e che fa morire.
Quest'ultimo aspetto è simboleggiato dalla lancia: tutte le Grandi Dee Madri furono anche Dee della guerra nel loro lato mortifero.
Quest'ultimo aspetto è simboleggiato dalla lancia: tutte le Grandi Dee Madri furono anche Dee della guerra nel loro lato mortifero.
Nelle calende di febbraio i Romani erano soliti illuminare l’Urbe, per tutta la notte, con fiaccole e candele, e le donne giravano per le strade portando fiaccole accese in onore della Dea Februa (Februa era stata assimilata a Giunone), madre di Marte, Dio della guerra, e invocavano il figlio per la vittoria contro i nemici.
« Gli antenati romani dissero Februe le espiazioni: e ancora molti indizi confermano tal senso della parola. I pontefici chiedono al re e al flamine le lane che nella lingua degli antichi erano dette februe. Gli ingredienti purificatori, il farro tostato e i granelli di sale, che il littore prende nelle case prestabilite, si dicono anch'essi februe. Da ciò il nome del mese, perché i Luperci con strisce di cuoio percorrono tutta la città, e ciò considerano rito di purificazione.»
(Ovidio, I Fasti)
I TEMPLI
Giunone Sospita (in latino Iuno Sospita, ossia "propizia"), già venerata a Roma in un tempio presso il Foro Olitorio, costruito verso il 195 a.c. da Gaio Cornelio Cetego, era particolarmente venerata nell'antica Lanuvium, molto celebre in tutto il Lazio antico, ed il I febbraio era considerato il suo dies natalis.
Un'antefissa raffigurante la dea è stata rinvenuta ad Antemnae, all'interno della Roma moderna, dove si è ipotizzato un luogo di culto della divinità. Si ricorda Cecilia Metella Balearica, vergine vestale e sacerdotessa della Dea Giunone Sospita, che salvò con il suo intervento Cesare da Silla che voleva ucciderlo.
IL SANTUARIO DI LANUVIO
Il principale centro di culto di questa divinità era appunto il santuario di Lanuvio.
Cicerone testimonia come Lanuvio fosse ricco di edifici religiosi, ma tra questi, spiccava il tempio di Giunone Sospita Lanuvina (così chiamata per la pelle di capra con la quale era rivestita la sua statua), il cui culto risaliva a tempi molto antichi.
Giunone Sospita (in latino Iuno Sospita, ossia "propizia"), già venerata a Roma in un tempio presso il Foro Olitorio, costruito verso il 195 a.c. da Gaio Cornelio Cetego, era particolarmente venerata nell'antica Lanuvium, molto celebre in tutto il Lazio antico, ed il I febbraio era considerato il suo dies natalis.
Un'antefissa raffigurante la dea è stata rinvenuta ad Antemnae, all'interno della Roma moderna, dove si è ipotizzato un luogo di culto della divinità. Si ricorda Cecilia Metella Balearica, vergine vestale e sacerdotessa della Dea Giunone Sospita, che salvò con il suo intervento Cesare da Silla che voleva ucciderlo.
IL SANTUARIO DI LANUVIO
Il principale centro di culto di questa divinità era appunto il santuario di Lanuvio.
Cicerone testimonia come Lanuvio fosse ricco di edifici religiosi, ma tra questi, spiccava il tempio di Giunone Sospita Lanuvina (così chiamata per la pelle di capra con la quale era rivestita la sua statua), il cui culto risaliva a tempi molto antichi.
Properzio narra infatti che nel santuario si svolgesse ogni primavera un particolarissimo rito propiziatorio per l’agricoltura, durante il quale un gruppo di fanciulle vergini doveva offrire focacce ad un grosso serpente, che si trovava dentro un antro!
Se il serpente accettava il dono, si prospettavano raccolti fruttuosi; se lo rifiutava, una fanciulla impura, cioè colei che aveva perduto la verginità, veniva sacrificata per scongiurare la carestia. Il serpente era anticamente allevato dalle pitonesse che oracolavano nel tempio della Madre Tellus, dove il pitone girava liberamente.
Se il serpente accettava il dono, si prospettavano raccolti fruttuosi; se lo rifiutava, una fanciulla impura, cioè colei che aveva perduto la verginità, veniva sacrificata per scongiurare la carestia. Il serpente era anticamente allevato dalle pitonesse che oracolavano nel tempio della Madre Tellus, dove il pitone girava liberamente.
Nessuno si sarebbe sognato di uccidere una pitonessa, anche perchè erano le sacerdotesse a interpretare e ad essere ispirate dalla Dea. Tutti gli oracoli, passati poi nelle mani dei sacerdoti persero completamente il dono della predizione e divennero una specie di indovinelli a risposta doppia.
L'importanza di questo santuario, viene testimoniato dai documenti storici: quando i Romani sconfissero la Lega Latina nel IV secolo, accettarono l'alleanza con i cittadini di Lanuvio, solo se questi in cambio avessero condiviso con loro il celebre luogo sacro dedicato a Giunone Sospita.
L'importanza di questo santuario, viene testimoniato dai documenti storici: quando i Romani sconfissero la Lega Latina nel IV secolo, accettarono l'alleanza con i cittadini di Lanuvio, solo se questi in cambio avessero condiviso con loro il celebre luogo sacro dedicato a Giunone Sospita.
Ma il tempio era ricchissimo perchè la Dea faceva molti miracoli, per cui la sua importanza non era solo religiosa.
Dunque il fatto che Giunone Sospita fosse chiamata Mater Regina, ovviamente Madre degli Dei, che venisse ricoperta da una pelle di capra (che da un lato la celava ma dall'altro rivelava la sua natura sessuale), e il fatto che fosse legata a una Dea delle febbri di palude, quindi portatrice di morte, confermano il suo aspetto triplice e in particolare il suo aspetto infero come regina dei morti.
LA FESTA
Proprio in quanto Regina dei morti la festa di Giunone Sospita proseguiva nella notte al lume delle fiaccole. Dopo il sacrificio pubblico si attuava la lunga processione che entrava casa per casa aspergendo gli ambienti con un liquido misto di acqua salata e sangue della vittima e recitando preghiere. Nelle campagne si aspergevano anche le stalle. In alcuni casi si aspergevano le porte e le stanze dei malati.
Il cristianesimo ne ha ripreso il culto nella benedizione delle case a Pasqua.
Alla processione partecipavano sacerdoti e sacerdotesse, perchè Giunone Sospita aveva anche sacerdotesse e sembra venisse recata anche una capra adornata. Naturalmente partecipava anche il popolo nell'abito festivo, con toni particolarmente allegri per fugare la negatività della malattia.
Terminata la processione iniziavano i banchetti che, almeno nei pagus, si tenevano nelle strade con laute mense e vino in abbondanza. Non mancavano musici e danzatori a cui si univa la gente locale per danzare e cantare.
LA FESTA
Proprio in quanto Regina dei morti la festa di Giunone Sospita proseguiva nella notte al lume delle fiaccole. Dopo il sacrificio pubblico si attuava la lunga processione che entrava casa per casa aspergendo gli ambienti con un liquido misto di acqua salata e sangue della vittima e recitando preghiere. Nelle campagne si aspergevano anche le stalle. In alcuni casi si aspergevano le porte e le stanze dei malati.
Il cristianesimo ne ha ripreso il culto nella benedizione delle case a Pasqua.
Alla processione partecipavano sacerdoti e sacerdotesse, perchè Giunone Sospita aveva anche sacerdotesse e sembra venisse recata anche una capra adornata. Naturalmente partecipava anche il popolo nell'abito festivo, con toni particolarmente allegri per fugare la negatività della malattia.
Terminata la processione iniziavano i banchetti che, almeno nei pagus, si tenevano nelle strade con laute mense e vino in abbondanza. Non mancavano musici e danzatori a cui si univa la gente locale per danzare e cantare.