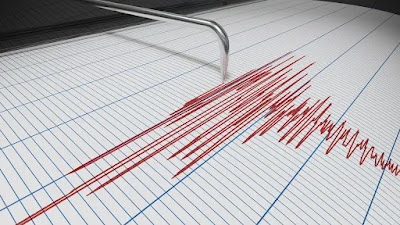PRESCRIZIONI DI SILLA( 1 ) Aveva quindici anni quando perse il padre; nell'anno successivo gli fu conferita la carica di Flamendiale. Separatosi da Cossuzia, donna di famiglia equestre, ma molto ricca, alla quale era stato fidanzato fin dalla più giovane età, sposò Cornelia, figlia di Cinna, quello stesso che era stato eletto console per quattro volte.
Da lei ebbe una figlia, Giulia, e neppure Silla poté costringerlo a divorziare; allora il dittatore lo privò della sua carica sacerdotale, della dote della moglie e dell'eredità familiare, inserendolo quindi nella lista dei suoi avversari. Cesare fu costretto così a starsene nascosto, a cambiare rifugio quasi ogni notte, quantunque ammalato piuttosto gravemente di febbre quartana.
Finalmente, per intercessione sia delle Vergini Vestali, sia di alcuni suoi parenti, ottenne la grazia. Si dice che Silla, rifiutatosi a lungo di accogliere le preghiere dei suoi più illustri amici e oppostosi tenacemente alle insistenti richieste, alla fine, vinto, abbia esclamato, non si sa bene se per intuizione o per uno strano presentimento:
«
Esultate e tenetevelo stretto, ma sappiate che colui che volete salvo ad ogni costo un giorno sarà la rovina del partito aristocratico che voi avete difeso insieme con me. In Cesare, infatti, sono nascosti molti Mari.»
![]() |
| MITRIDATE |
L'AMANTE DI NICOMEDE( 2 ) Fece il servizio di leva in Asia, presso lo stato maggiore di Marco Termo. Mandato da costui in Bitinia per cercare una flotta, si attardò presso Nicomede e qui corse voce che si fosse prostituito a quel re.
Egli stesso alimentò questa diceria quando, pochi giorni più tardi, ritornò in Bitinia con la scusa di ricuperare un credito concesso ad uno schiavo affrancato, divenuto suo cliente.
Tuttavia gli ultimi anni della sua campagna militare gli procurarono una fama migliore e Termo, in occasione della conquista di Mitilene, gli fece assegnare la corona civica.
( 3 ) Prestò servizio anche in Cilicia, agli ordini di Servilio Isaurico, ma per poco tempo. Era giunta infatti la notizia della morte di Silla e allora, con la speranza di qualche nuova discordia, che già si profilava per opera di Marco Emilio Lepido, si affrettò a rientrare a Roma.
Qui tuttavia, nonostante le vantaggiose proposte, si guardò bene dal far lega con lo stesso Lepido, perché diffidava delle sue capacità e soprattutto perché gli sembrava che le circostanze fossero meno favorevoli di quanto avesse immaginato.
( 4 ) Quando la discordia civile fu domata, Cesare incriminò per concussione Cornelio Dolabella, un ex console che aveva meritato il trionfo.
Poiché l'imputato era stato assolto, decise di andarsene a Rodi, un po' per sottrarsi ad eventuali vendette, un po' per seguire durante quel periodo di inattività e di riposo, le lezioni di Apollonio Molone, a quel tempo il più celebre maestro di oratoria.
Durante la navigazione verso Rodi, avvenuta nella stagione invernale, fu fatto prigioniero dai pirati presso l'isola di Farmacusa, e rimase con loro, non senza la più viva indignazione, per circa quaranta giorni, in compagnia di un medico e di due schiavi.
I compagni di viaggio, infatti, e tutti gli altri servi erano stati inviati immediatamente a Roma per raccogliere i soldi del riscatto.
Quando furono pagati i cinquanta talenti stabiliti, venne sbarcato su una spiaggia e allora, senza perdere tempo, assoldò una flotta e si lanciò all'inseguimento dei pirati: li catturò e li condannò a quel supplizio che spesso aveva minacciato loro per scherzo.
Mitridate, intanto, devastava le regioni vicine al suo regno e Cesare, per non apparire inattivo, mentre altri si trovavano in difficoltà, da Rodi, dove era giunto, passò in Asia con un certo numero di truppe che aveva raccolto, scacciò dalla provincia il luogotenente del re e ridiede fiducia alle popolazioni incerte e dubbiose.
( 5 ) Durante il suo tribunato militare, la prima carica che ottenne con il suffragio popolare dopo il suo ritorno a Roma, appoggiò vigorosamente coloro che volevano ripristinare l'autorità tribunizia, da Silla indebolita. Fece poi votare la legge Plozia che concedeva il ritorno in patria a Lucio Cornelio Cinna, fratello di sua moglie, e a quelli che, con lui, al tempo della sommossa civile, prima avevano seguito Lepido e poi, alla sua morte, si erano rifugiati presso Sertorio. Sull'argomento tenne addirittura una pubblica arringa.
I FUNERALI DELLA ZIA E L'ORAZIONE( 6 ) Quando divenne questore, dalla tribuna dei rostri pronunciò, secondo la consuetudine, il discorso funebre in onore della zia Giulia e della moglie Cornelia che erano morte. Proprio nell'elogio della zia riferì di lei e di suo padre questa duplice origine:
«
La stirpe materna di mia zia Giulia ha origine dai re, quella paterna si congiunge con gli Dei immortali. Infatti da Anco Marzio discendono i Marzii, e tale fu il nome di sua madre. Da Venere hanno origine i Giulii, alla cui gente appartiene la nostra famiglia. Vi è dunque nella stirpe la santità dei re, che si innalzano sugli uomini, e la solennità degli Dei, sotto il cui potere si trovano gli stessi re."Rimpiazzò poi Cornelia con Pompea, figlia di Quinto Pompeo e nipote di L. Silla; da lei divorziò più tardi, sospettandola di adulterio con Publio Clodio. Si andava dicendo che Clodio si era introdotto da lei, in vesti femminili, durante una pubblica cerimonia religiosa. Il Senato dovette ordinare un'inchiesta per sacrilegio.
![]() |
| PUBLIO CLODIO PULCRO |
PIANTO SULLA TOMBA DI ALESSANDRO( 7 ) Sempre come questore gli fu assegnata la Spagna Ulteriore; qui, con delega del pretore, percorse i luoghi di riunione per amministrare la giustizia, finché giunse a Cadice dove, vista la statua di Alessandro Magno presso il tempio di Ercole, si mise a piangere, quasi vergognandosi della sua inettitudine. Pensava infatti di non aver fatto nulla di memorabile all'età in cui Alessandro aveva già sottomesso il mondo intero.
Allora chiese subito un incarico a Roma per cogliere al più presto l'occasione di compiere grandi imprese. Nello stesso tempo, turbato da un sogno della notte precedente (aveva sognato infatti di violentare sua madre) fu incitato a nutrire le più grandi speranze dagli stessi indovini che gli vaticinarono il dominio del mondo quando gli spiegarono che la madre, che aveva visto giacere sotto di lui, altro non era che la terra stessa, considerata appunto madre di tutti.
( 8 ) Lasciata dunque, prima del tempo, la provincia, si recò a visitare le colonie latine che lottavano per ottenere i diritti di cittadinanza. Molto probabilmente avrebbe tentato qualche grosso colpo se i consoli, prevenendo i suoi progetti, non avessero trattenuto per un po' di tempo le legioni arruolate per un'operazione militare in Cilicia.
( 9 ) Non di meno anche a Roma tentò qualcosa di più grande: infatti pochi giorni prima di accedere alla carica di edile venne sospettato di aver complottato con l'ex console Marco Crasso, d'accordo con Publio Silla e con Lucio Autronio, condannati per broglio elettorale, dopo essere stati designati consoli.
Il piano prevedeva di attaccare il rituale riservato esclusivamente alle donne, ma evidentemente Clodio non aveva scrupoli di nessun genere. Avrebbero quindi attaccato il Senato al principio dell'anno e ucciso tutti quelli che avevano preventivamente stabilito. Compiuta la strage, Crasso sarebbe divenuto dittatore, Cesare sarebbe stato da lui nominato maestro della cavalleria e, organizzato lo Stato a loro piacimento, sarebbe stato riconferito il consolato a Silla e Autronio.
Fanno menzione di questa congiura Tanusio Gemino, nella sua storia, Marco Bibulo nei suoi editti, e Caio Curione, il padre, nelle sue orazioni. Anche Cicerone, in una lettera ad Axio, sembra alludere a questo complotto quando dice che Cesare, una volta console, si assicurò quella sovranità che si era promesso come edile.
Tanusio aggiunge che Crasso, o perché pentito, o perché timoroso, non si fece vedere il giorno stabilito per la strage, e di conseguenza neppure Cesare diede il segnale che si era convenuto secondo gli accordi. Curione dice che, come segnale, Cesare avrebbe dovuto far cadere la toga dalla spalla.
Lo stesso Curione, ma anche Marco Actorio Nasone affermano che aveva pure cospirato con il giovane Gneo Pisone, al quale, proprio perché sospettato di una congiura a Roma, sarebbe stata assegnata, in via straordinaria, la provincia spagnola. Si sarebbero accordati per provocare una rivoluzione, nello stesso tempo, Pisone fuori e Cesare a Roma, facendo insorgere gli Ambroni e i Galli Traspadani. La morte di Pisone mandò a monte il duplice progetto.
CESARE UNICO CONSOLE( 10 ) Quando era edile adornò non solo il comizio, ma anche il foro e le basiliche di portici provvisori per esporvi una parte delle molte opere d'arte che possedeva.
![]() |
| MARCO BIBULO |
Organizzò, o con la collaborazione del collega in carica, o per conto proprio, battute di caccia e giochi; così avvenne che anche delle spese sostenute in comune si ringraziava soltanto lui.
E il suo collega Marco Bibulo non nascondeva che gli era toccata la stessa sorte di Polluce: come infatti il tempio dei due fratelli gemelli, eretto nel foro, veniva indicato soltanto con il nome di Castore, così la generosità sua e di Cesare solo a Cesare era attribuita.
Per di più Cesare offrì anche un combattimento di gladiatori, tuttavia meno grandioso di quello che aveva progettato.
La verità era che i suoi nemici si erano preoccupati perché aveva raccolto da ogni parte una enorme quantità di gladiatori: per questo si stabilì che a nessun cittadino fosse lecito possederne in Roma più di un certo numero.
( 11 ) Guadagnatosi il favore del popolo, con l'aiuto di alcuni tribuni brigò per farsi assegnare, attraverso un plebiscito, la provincia dell'Egitto; vedeva là l'occasione di ottenere un comando straordinario, perché gli abitanti di Alessandria avevano scacciato il loro re, che il Senato aveva dichiarato amico e alleato. L'atto di rivolta era stato disapprovato a Roma.
Tuttavia, per l'opposizione degli ottimati, non ottenne lo scopo; allora, per ridurre in qualunque modo possibile la loro influenza, ripristinò i trofei delle vittorie di Mario su Giugurta, sui Cimbri e sui Teutoni, a suo tempo rimossi da Silla.
Trattando poi la questione dei sicari, considerò tali anche coloro che, durante il periodo delle proscrizioni, avevano ricevuto denari dall'erario per essere stati delatori di alcuni cittadini romani. E ciò nonostante le eccezioni previste dalle leggi Cornelie.
( 12 ) Convinse anche qualcuno a trascinare in giudizio Gaio Rubinio per alto tradimento. Grazie al suo aiuto, infatti, il Senato, alcuni anni prima, aveva represso un tentativo di sedizione del tribuno Lucio Saturnino. Sorteggiato come giudice del colpevole, ci mise tanto impegno a condannarlo che Rubinio, appellatosi al popolo, trovò la sua miglior difesa proprio nella severità del suo giudice.
LA CARICA DI PONTEFICE( 13 ) Deposta la speranza di avere il comando di una provincia, si diede da fare per ottenere la dignità di pontefice massimo, naturalmente con grandi elargizioni di denaro. Così, pensando all'enormità dei suoi debiti, sembra che, avviandosi alle elezioni, abbia detto alla madre che lo abbracciava: «
Non tornerò a casa se non con la carica di pontefice.»
In tal modo batté due competitori assai potenti, che lo superavano sia per età, sia per dignità, anzi ottenne più suffragi nelle loro tribù che quei due in tutte le altre messe insieme.
![]() |
| LUCIO SERGIO CATILINA |
LA CONGIURA DI CATILINA( 14 ) Era pretore quando venne scoperta la congiura di Catilina e mentre compatto il Senato decretava la pena di morte per i congiurati, lui solo sostenne che si doveva imprigionarli separatamente nelle città municipali e confiscare i loro averi.
A furia di mostrare che il popolo romano avrebbe in seguito provato invidia per loro, gettò un tal panico tra i fautori della severità ad oltranza, che il console designato Decimo Silano non si vergognò di dare un'interpretazione più addolcita della sua sentenza, proprio perché sarebbe stato vergognoso cambiarla.
Disse che era stata presa in un senso più rigoroso di quanto egli stesso intendesse. Cesare avrebbe ottenuto lo scopo perché erano già passati dalla sua parte moltissimi senatori, tra i quali anche Cicerone, il fratello del console, ma il discorso di Marco Catone convinse finalmente il Senato indeciso.
Anche allora, tuttavia, egli non rinunciò alla sua opposizione, finché una schiera di cavalieri romani che se ne stava in armi attorno alla curia per sorvegliare, lo minacciò di morte, per la sua eccessiva insistenza, dirigendo contro di lui le spade sguainate.
Coloro che gli erano seduti vicino si allontanarono e a stento alcuni amici riuscirono a proteggerlo, prendendolo fra le braccia e riparandolo con la toga. Veramente spaventato, questa volta, non solo desistette, ma per il resto dell'anno non si fece più vedere in Senato.
( 15 ) Il primo giorno della sua pretura citò davanti al popolo Quinto Catulo per un'inchiesta sulla ricostruzione del Campidoglio, presentando nello stesso tempo un progetto di legge che affidava ad un altro l'appalto di quei lavori; troppo debole, però, di fronte alla coalizione degli ottimati che, abbandonato il servizio d'onore ai nuovi consoli, vedeva correre numerosi e decisi a resistere alle sue intenzioni, lasciò cadere anche questo proposito.
( 16 ) Ma quando Cecilio Metello, tribuno della plebe, volle far passare, contro il parere dei colleghi, alcune leggi chiaramente sovversive, se ne mostrò il più grande sostenitore e il più costante difensore, finché tutti e due, per decreto del Senato, furono rimossi dalle loro funzioni politiche. Ciò nonostante ebbe il coraggio di restare in carica e di continuare ad amministrare la giustizia.
Quando poi venne a sapere che si stavano preparando per impedirgli ogni attività con la forza delle armi, congedati i suoi littori e deposta la sua pretesta, si ritirò segretamente in casa, deciso, per il momento critico, a starsene tranquillo. Arrivò perfino, due giorni dopo, a placare la folla che si era spontaneamente riunita sotto la sua casa per promettergli rumorosamente di aiutarlo a riprendere la sua carica.
Poiché il fatto avvenne contro ogni aspettativa, il Senato, che in fretta si era riunito proprio a causa di quell'assembramento, lo ringraziò attraverso i cittadini più in vista, lo fece chiamare in curia, lo lodò con belle parole e lo reintegrò nelle sue cariche, dopo aver revocato il precedente decreto.
SOSPETTI SU CESARE COME COMPLICE DI CATILINA( 17 ) Ma incorse ancora in un altro inconveniente quando venne denunciato come complice di Catilina, prima davanti al questore Novio Negro, su delazione di Lucio Vettio, poi davanti al Senato, su delazione di Quinto Curio.
A costui erano stati assegnati premi pubblici perché aveva svelato per primo i piani dei congiurati. Curio sosteneva di aver saputo da Catilina la complicità di Cesare e Vettio arrivava a promettere di mostrare un biglietto autografo, scritto da Cesare per Catilina.
Pensando di non dovere in nessun modo sopportare una simile accusa, Cesare dimostrò, invocando la testimonianza di Cicerone, che proprio lui aveva svelato al console alcuni dettagli della congiura e fece in modo che nessuna ricompensa fosse assegnata a Curio.
Quanto a Vettio, gli si inflisse un sequestro, si presero i suoi mobili, fu maltrattato e quasi messo alla berlina, in piena assemblea, davanti ai rostri; dopo di che Cesare lo fece mettere in prigione. Con lui vi cacciò anche il questore Novio, perché aveva permesso che davanti a lui venisse accusato un magistrato di grado superiore.
![Risultati immagini per romanoimpero cesare]() |
| GIULIO CESARE |
CESARE OTTIENE LA SPAGNA ULTERIORE( 18 ) Allo scadere del suo mandato di pretore, gli fu assegnata la Spagna Ulteriore; i suoi creditori, però, non lo lasciavano partire, ma si sbarazzò di loro con l'aiuto di gente che garantisse per lui. Quindi, contrariamente alla consuetudine e alle leggi, partì prima ancora che le province fossero dotate di tutto il necessario. Non è ben chiaro se lo fece per timore di un processo che gli si stava intentando privatamente, o per recare aiuto con più tempestività agli alleati che lo invocavano.
Pacificata la provincia, con altrettanta rapidità, senza attendere il suo successore, tornò a Roma, per chiedere contemporaneamente sia il trionfo, sia il consolato. Le elezioni, però, erano già state indette e quindi non si poteva tener conto della sua candidatura, a meno che non fosse entrato in città come privato cittadino. Brigò per ottenere una deroga dalla legge, ma molti gli si opposero. Così, per non essere escluso dal consolato, fu costretto a differire il trionfo.
( 19 ) Dei due competitori al consolato, Lucio Luccio e Marco Bibulo, egli si associò al primo, con il patto che, essendo quello inferiore per prestigio, ma stimabile per patrimonio, promettesse a tutte le centurie, in nome di tutti e due, notevoli elargizioni di denaro, che avrebbe concesso attingendo dai propri fondi.
Risaputo l'accordo gli ottimati, presi dal timore che Cesare, una volta ottenuta la massima carica, si sarebbe permesso di tutto, con il consenso e l'appoggio del collega, raccomandarono a Bibulo di fare promesse dello stesso genere, e molti misero a disposizione i denari.
Perfino Catone sostenne che tali elargizioni giovavano allo Stato. Fu così che Cesare venne eletto console insieme con Bibulo. Per questa stessa ragione gli ottimati si diedero da fare perché ai futuri consoli venissero assegnate province di poco conto, più precisamente zone di boschi e di pascoli.
Colpito profondamente da queste ingiustizie, Cesare si mise a corteggiare in mille modi Gneo Pompeo, che dal canto suo era irritato con i senatori perché tardavano a ratificare i suoi atti dopo la vittoria sul re Mitridate.
Cesare riuscì a riconciliare Marco Crasso con Pompeo, separati da un'antica rivalità fin dai tempi in cui esercitarono il consolato nel disaccordo più completo: insomma strinse con loro un'alleanza, in base alla quale non si doveva fare niente, nell'ambito dello Stato, che potesse dispiacere a uno dei tre.
![]() |
| GNEO POMPEO MAGNO |
IL TRIUNVIRATO( 20 ) Entrato in carica, Cesare per prima cosa stabilì che tutti gli atti, sia del Senato sia del popolo, venissero resi pubblici. Ristabilì inoltre l'antica usanza, secondo la quale nel mese in cui non disponeva di fasci, fosse preceduto da un messo e subito seguito dai littori. Promulgò poi una legge agraria, e quando il suo collega tentò di opporsi, lo fece cacciare dal foro con le armi.
Il giorno dopo Bibulo si lamentò in Senato, ma non trovò nessuno che osasse fare un rapporto su un simile atto di violenza e proporre misure che già erano state prese in circostanze di ben minor gravità. Fu talmente scoraggiato, che, per tutta la durata della sua carica, se ne stette nascosto in casa, limitandosi a manifestare la sua opposizione solo per mezzo di comunicati.
Da quel momento Cesare regolò da solo, e a suo piacimento, tutti gli affari dello Stato: fu così che alcune persone spiritose, dovendo datare un atto per renderlo autentico, scrivevano che era stato redatto non durante il consolato di Bibulo e Cesare, ma di Giulio e Cesare, nominando due volte la stessa persona, prima con il nome, poi con il soprannome.
Ben presto insomma cominciarono a correre tra il popolo questi versi: «
Non Bibulo, ma Cesare ha fatto la tal cosa; Non ricordo che Bibulo, da console, abbia fatto qualcosa.»
Il campo di Stella, consacrato dagli antenati, e l'Agro Campano, che era rimasto soggetto ad imposte per i bisogni dello Stato, furono divisi da Cesare, senza estrazione a sorte, tra ventimila cittadini che avevano tre o più figli.
Quando gli esattori delle imposte vennero a chiedere un alleggerimento del canone di appalto, condonò loro un terzo, ma raccomandò anche pubblicamente di non essere sfrenati nell'aggiudicare nuove imposte.
Per il resto elargiva favori a chiunque glieli chiedesse, senza che nessuno facesse opposizione, e se qualcuno ci si provava, lo minacciava fino a spaventarlo. Marco Catone gli si oppose, ed egli lo fece uscire dalla curia per mezzo di un littore e condurre in prigione.
Lucio Lucullo, con eccessivo ardimento, provò a resistergli: Cesare gli gettò addosso una tale paura con insinuazioni calunniose che spontaneamente quello si gettò ai suoi piedi. Cicerone, durante un processo, deplorò le condizioni dei tempi: Cesare, nello stesso giorno, alle tre del pomeriggio, fece passare Publio Clodio, nemico personale dell'oratore, dalla classe dei patrizi a quella della plebe, favore che Clodio già in precedenza aveva tentato invano di ottenere.
Infine contro tutti i nemici di diversa fazione cercò di ricorrere a un delatore che, corrotto dal denaro, si prestasse a dichiarare che era stato sollecitato da alcuni di loro ad uccidere Pompeo e salisse sui rostri per indicare, secondo i suoi suggerimenti, gli istigatori del crimine.
Il disgraziato però cominciò a confondersi dopo aver pronunciato due nomi, cosa che fece sospettare la frode. Cesare allora cominciò a pensare che un'impresa così temeraria non avrebbe avuto successo e fece sopprimere il delatore: pare con il veleno.
![]() |
| CALPURNIA |
CALPURNIA( 21 ) Nello stesso periodo di tempo Cesare sposò Calpurnia, figlia di Lucio Pisone, che gli sarebbe succeduto nel consolato, e diede in moglie a Gneo Pompeo la propria figlia Giulia, dopo averla fatta divorziare dal precedente marito Servilio Cepione, con l'aiuto del quale, poco prima, aveva combattuto contro Bibulo.
Stabilita questa nuova parentela, prese l'abitudine di chiedere per prima cosa il parere di Pompeo, anziché quello di Crasso, come era solito fare, benché fosse tradizione che il console, durante tutto l'anno, chiedesse i pareri secondo l'ordine che aveva introdotto al primo di gennaio.
LA PROVINCIA DELLE GALLIE( 22 ) Così, con l'appoggio del suocero e del genero, fra le tante province, scelse le Gallie, pensando che vi avrebbe trovato non poche risorse e occasioni favorevoli per riportarvi trionfi. Tuttavia all'inizio gli fu assegnata soltanto la Gallia Cisalpina con l'aggiunta dell'Illirico, in forza della legge Vatinia. Ben presto, però, il Senato vi unì anche la Transalpina, perché i senatori temevano che se gliel'avessero negata, l'avrebbe avuta dal popolo.
Al colmo della gioia, Cesare non seppe più contenersi e alcuni giorni più tardi si vantò, davanti a numerosi senatori, di aver ottenuto quello che desiderava, nonostante le opposizioni e le lagnanze dei suoi avversari, e che ormai da quel momento avrebbe potuto farsi beffe di tutti.
Un senatore, con il preciso scopo di offenderlo, dichiarò che ciò non sarebbe stato facile per una donna, ma Cesare, con l'aria di stare allo scherzo, rispose che anche Semiramide aveva regnato in Siria e che le Amazzoni avevano dominato su gran parte dell'Asia.
CESARE MINACCIATO DI GIUDIZIO( 23 ) Allo scadere del consolato, i pretori Gaio Memmio e Lucio Domizio presentarono una relazione sui fatti dell'anno precedente: allora Cesare deferì al Senato l'istruzione dell'affare, ma poiché il Senato non se ne occupava, e tre giorni erano stati perduti in varie discussioni, se ne partì per la provincia.
Subito il suo questore fu trascinato in giudizio sotto varie imputazioni, in vista di un'inchiesta pregiudiziale. Ben presto fu citato anche lui da Lucio Antistio, tribuno della plebe, e dovette alla fine appellarsi al collegio dei tribuni per ottenere di non essere accusato, dal momento che era assente per servizio di Stato.
Così, allo scopo di garantirsi in avvenire la propria sicurezza, si diede da fare per legare a sé ogni anno i vari magistrati in carica e sostenere o lasciar giungere agli onori soltanto quei candidati che si fossero impegnati a difenderlo durante la sua assenza. Di questo accordo non esitò a pretendere da alcuni un giuramento e perfino una dichiarazione scritta.
LA PROROGA DEL CONSOLATO
( 24 ) Ma quando Lucio Domizio, candidato al consolato, lo minacciò pubblicamente di realizzare come console ciò che non aveva potuto fare come pretore e di togliergli il comando delle truppe, convinse Crasso e Pompeo, che aveva convocato a Lucca, città della sua provincia, a concorrere per un altro consolato, allo scopo di ostacolare Domizio, e riuscì, con l'appoggio di entrambi, ad ottenere la proroga del suo comando per un altro quinquennio.
Forte di questo successo, aggiunse, a proprie spese, altre legioni a quelle che aveva ricevuto dallo Stato. Una di queste fu reclutata fra i Galli transalpini e chiamata con nome gallico (quello di Alauda), ma fu addestrata secondo la disciplina e la tradizione romane. Più tardi la gratificò tutta quanta del diritto di cittadinanza.
In seguito non trascurò nessuna occasione di fare la guerra, anche a dispetto della giustizia, e di recar danno sia agli alleati, sia alle popolazioni nemiche e selvagge, apertamente provocate, tanto che il Senato, un bel momento, decise di inviare alcuni commissari per accertare la situazione delle Gallie.
Alcuni senatori arrivarono perfino a proporre di consegnarlo al nemico, ma poiché tutte le sue imprese avevano successo, egli ottenne pubblici ringraziamenti più spesso e più a lungo di qualunque altro generale.
NOVE ANNI DI GUERRE( 25 ) Ecco in sintesi le sue imprese durante i nove anni di comando. Ad eccezione delle città alleate e di quelle che avevano acquisito meriti davanti a Roma, ridusse alla condizione di provincia tutta la Gallia compresa tra le catene dei Pirenei, delle Alpi e delle Cevenne e i fiumi Reno e Rodano, che si estende per tre milioni e duecentomila passi e vi impose un tributo annuo di quaranta milioni di sesterzi.
Primo fra i Romani, aggredì i Germani, abitanti oltre il Reno, dopo aver costruito un ponte sul fiume, e inflisse loro gravi sconfitte. Mosse anche contro i Britanni, fino a quel tempo sconosciuti, e dopo averli battuti li costrinse a consegnare ostaggi e a versare tributi.
In mezzo a tanti successi si trovò in difficoltà non più di tre volte: in Britannia la sua flotta fu quasi interamente distrutta da una tempesta; in Gallia, sotto le mura di Gergovia, una sua legione fu messa in fuga; infine nel territorio dei Germani i suoi luogotenenti Titurio e Arunculeio perirono in un'imboscata.
CESARE INIZIA LA COSTRUZIONE DEL NUOVO FORO( 26 ) Nello stesso periodo di tempo gli morirono prima la madre, poi la figlia e infine, non molto dopo, anche la nipote. Mentre era colpito da tante disgrazie personali, lo Stato venne sconvolto dalla morte di Publio Clodio.
Il Senato era dell'avviso di nominare un solo console, e precisamente Gneo Pompeo, ma Cesare convinse i tribuni della plebe, che volevano eleggerlo come collega dello stesso Pompeo, a proporre piuttosto al popolo di permettergli, benché fosse lontano, di concorrere ad un altro consolato quando sarebbe stata prossima la scadenza del suo mandato di comando.
In tal modo non sarebbe stato costretto a lasciare anzi tempo la provincia, prima che la guerra fosse conclusa. Quando ottenne questa concessione, pieno di speranza, già meditando imprese più ambiziose, profuse elargizioni e favori di ogni genere a tutti, pubblicamente e privatamente. Con i proventi dei bottini di guerra avviò la costruzione di un Foro, il cui terreno venne a costare più di cento milioni di sesterzi.
Annunciò al popolo uno spettacolo di gladiatori e un ricco banchetto in memoria della figlia morta, cosa che nessuno aveva mai fatto prima di lui. Allo scopo di creare un grande stato di attesa per questa manifestazione, faceva preparare tutto ciò che riguardava il banchetto in case private, sebbene avesse affidato l'incarico a personale specializzato.
Dovunque vi fossero gladiatori famosi, costretti a combattere davanti ad un pubblico ostile, dava ordine di prelevarli, magari anche con la forza, e di riservarglieli.
Quanto agli allievi gladiatori, non li faceva addestrare nelle scuole e nemmeno sotto le direttive di maestri professionisti, ma in case private, per mezzo di cavalieri romani e perfino di senatori esperti nell'uso delle armi; li andava supplicando, come confermano le sue lettere, di addossarsi la responsabilità della disciplina dei singoli allievi e di dirigere personalmente gli esercizi.
Per quanto si riferisce alle legioni, raddoppiò definitivamente la paga. Ogni volta che vi era abbondanza di grano, lo fece distribuire senza limitazioni e misura, e assegnò a ciascuno, di tanto in tanto, uno schiavo preso dal bottino di guerra.
CESARE ELARGISCE DONI E SPETTACOLI(
27 ) Allo scopo di conservare la parentela con Pompeo e la sua amicizia, gli offrì la mano di Ottavia, nipote di sua sorella, che aveva già maritato a Gaio Marcello, mentre lui personalmente chiese in moglie la figlia di Pompeo, destinata a Fausto Silla.
Vincolati a sé tutti coloro che erano vicini a Pompeo e anche una parte dei senatori mediante prestiti gratuiti o a basso interesse, quando venivano a trovarlo cittadini di altri ordini sociali, sia perché li aveva fatti chiamare, sia di loro iniziativa, li colmava di ogni generosità, senza dimenticare i liberti e gli schiavetti di ciascuno, per quanto fossero ben accetti al loro padrone o patrono.
Inoltre gli accusati, gli oppressi dai debiti e i giovani prodighi trovavano in lui un aiuto unico e tempestivo, a meno che il peso delle loro colpe, della loro miseria o dei loro disordini fosse superiore alle sue possibilità di aiuto; in tal caso diceva loro, senza mezzi termini, che «
avevano bisogno di una guerra civile».
( 28 ) Non minore impegno ci metteva ad accattivarsi la simpatia dei re e di tutte le province della terra, ora mandando in dono migliaia e migliaia di prigionieri, ora, senza chiedere l'autorizzazione del Senato e del popolo, inviando truppe ausiliarie dove e tutte le volte che volessero e per di più abbellendo con opere insigni le più potenti città dell'Italia e della Gallia.
Alla fine un po' tutti cominciarono a domandarsi, con un certo stupore, dove avesse intenzione di arrivare, e il console Marco Claudio Marcello, dopo aver annunciato con un editto che intendeva prendere provvedimenti nell'interesse dello Stato, fece un rapporto al Senato; vi si chiedeva di dare un successore a Cesare prima ancora che scadesse il suo tempo legale, perché, conclusa ormai la guerra, doveva esservi la pace e si doveva congedare un esercito vittorioso.
Sosteneva ancora che, per le elezioni, non si doveva tener conto della sua candidatura mentre era assente, dal momento che Pompeo, in seguito, aveva abrogato lo stesso plebiscito. Era accaduto infatti che Pompeo, presentando una legge sullo stato giuridico dei magistrati, vi aveva introdotto un articolo che impediva agli assenti di concorrere alle cariche, e si era dimenticato di fare almeno un'eccezione in favore di Cesare; più tardi aveva corretto la dimenticanza, ma quando ormai la legge era già incisa nel bronzo e conservata presso il Tesoro.
Marcello, non contento di togliere a Cesare sia le province, sia i privilegi, propose anche di revocare la cittadinanza a quei coloni che aveva stanziato a Novo Como in forza della legge Vatinia: sosteneva che era stata concessa con intenzioni demagogiche e al di là delle prescrizioni della legge.
![]() |
| IL SENATO |
IL SENATO OSTACOLA CESARE( 29 ) Preoccupato per queste macchinazioni e convinto, come sembra lo si sia sentito dire spesso, che era più difficile, finché occupava il primo posto nello Stato, resistette con tutte le sue forze, sia per l'intervento dei tribuni, sia per quello di Servio Sulpicio, l'altro console.
L'anno successivo fece gli stessi tentativi Gaio Marcello, che era succeduto nel consolato a suo cugino Marco, ma Cesare, spendendo somme enormi, si procurò, come difensori, Emilio Paolo, il collega di Marcello, e Gaio Curione, uno dei più violenti tribuni della plebe.
Vedendo però che ci si accaniva contro di lui con maggiore ostinazione e che erano stati designati come consoli perfino due suoi avversari, scrisse al Senato pregandolo di non togliergli un comando concessogli dal popolo, o altrimenti di rimuovere dai loro eserciti anche gli altri generali.
Pensava, come credono, che avrebbe potuto convocare quando volesse i suoi veterani in un tempo più breve di quello impiegato da Pompeo per fare nuove leve. Agli avversari propose di congedare otto legioni, abbandonando la Gallia Transalpina, e di tenere per sé due legioni e la Gallia Cisalpina, o almeno una legione con l'Illirico, fino a quando fosse stato eletto console.
( 30 ) Il Senato però non rispose e gli avversari si rifiutarono di scendere a patti per questioni che riguardavano lo Stato; egli allora scese nella Gallia citeriore, quindi, tenute le sue riunioni, si fermò a Ravenna, ben deciso a vendicare con la guerra quei tribuni che facevano opposizione in suo favore, qualora il Senato avesse preso provvedimenti troppo severi nei loro confronti.
Fu questo per lui il pretesto della guerra civile, ma si crede che altre siano state le cause. Pompeo andava dicendo che, vedendosi impossibilitato a portare a termine i monumenti iniziati e a realizzare, con le sue sole risorse, le speranze che aveva fatto concepire al popolo per il suo ritorno, egli aveva voluto precipitare ogni cosa nel caos.
Altri dicono che temesse di essere costretto a rendere ragione di ciò che aveva fatto durante il suo primo consolato, senza tener conto né degli auspici, né delle leggi, né dell'opposizione dei magistrati; M. Catone annunciò più di una volta, e non senza accompagnamento di giuramenti, che lo avrebbe trascinato in giudizio nel momento stesso in cui avesse congedato l'esercito.
Si diceva apertamente che se fosse tornato senza nessuna carica, seguendo l'esempio di Milone, avrebbe sostenuto la sua causa davanti a giudici circondati da uomini armati.
Rende credibile la cosa Asinio Pollione quando riferisce che, dopo la battaglia di Farsalo, vedendo i suoi avversari fatti a pezzi e completamente battuti, Cesare disse queste testuali parole:
«
Lo hanno voluto loro: dopo tante imprese io, Gaio Cesare, sarei stato condannato se non avessi chiesto aiuto ai miei soldati.»
Alcuni ritengono che sia stato condizionato dall'abitudine del comando e che abbia colto l'occasione di conquistare il potere supremo, da lui ardentemente desiderato fin dalla prima giovinezza, dopo aver saggiamente valutato le sue forze e quelle del nemico.
Anche Cicerone sembrava seguire questa opinione, perché nel terzo libro della sua opera «Dei doveri» dice che Cesare aveva sempre sulle labbra i versi di Euripide (si trovano nelle «Fenicie»:
«
Quando si deve commettere ingiustizia, bellissima è l'ingiustizia per il potere; per il resto si deve essere pietosi» che egli stesso così aveva tradotto: «
Giacché se il diritto si deve violare, violarlo si deve per la conquista del regno; in tutto il resto osserva la pietà».
![]() |
| RAVENNA HISTORIA MUNDI - RICOSTRUZIONE STORICA |
CESARE DECIDE DI PRENDERE IL POTERE( 31 ) Quando dunque gli fu riferito che non si era tenuto conto dell'opposizione dei tribuni e che questi avevano abbandonato Roma, subito fece andare avanti segretamente alcune coorti, per non destare sospetti.
Poi, con lo scopo di trarre in inganno, si fece vedere ad uno spettacolo pubblico, esaminò i progetti di una scuola di gladiatori che aveva intenzione di costruire e, secondo le sue abitudini, pranzò in numerosa compagnia.
Dopo il tramonto del sole, aggiogati ad un carro i muli di un vicino mulino, partì in gran segreto, con un'esile scorta. Quando le fiaccole si spensero, smarrì la strada e vagò a lungo, finché all'alba, trovata una guida, raggiunse a piedi la meta, attraverso sentieri strettissimi.
Riunitosi alle sue coorti presso il fiume Rubicone, che segnava il confine della sua provincia, si fermò per un attimo e, considerando quanto stava per intraprendere, si rivolse a quelli che gli erano più vicini dicendo:
«
Siamo ancora in tempo a tornare indietro, ma se attraverseremo il ponticello, dovremo sistemare ogni cosa con le armi.»
![]() |
| CESARE SUL RUBICONE |
PASSAGGIO DEL RUBICONE( 32 ) Mentre esitava, gli si mostrò un segno prodigioso. Un uomo di straordinaria bellezza e di taglia atletica apparve improvvisamente seduto poco distante, mentre cantava, accompagnandosi con la zampogna.
Per ascoltarlo, oltre ai pastori, erano accorsi dai posti vicini anche numerosi soldati e fra questi alcuni trombettieri: l'uomo allora, strappato a uno di questi il suo strumento, si slanciò nel fiume, suonando a pieni polmoni una marcia di guerra, e si diresse verso l'altra riva.
Allora Cesare disse: «
Andiamo dove ci chiamano i segnali degli Dei e l'iniquità dei nostri nemici. Il dado è tratto.»
( 33 ) Fatta passare così la sua armata, prese con sé i tribuni della plebe che, scacciati da Roma, gli si erano fatti incontro, si presentò davanti all'assemblea dei soldati e invocò la loro fedeltà con le lacrime agli occhi e la veste strappata sul petto.
Si crede perfino che abbia promesso a ciascuno il censo di cavaliere, ma si trattò di un equivoco. Infatti, nel corso della sua arringa e delle sue esortazioni, egli mostrò molto spesso il dito della mano sinistra dicendo che di buon grado si sarebbe tolto anche l'anello per ricompensare tutti coloro che avessero contribuito alla difesa del suo onore.
I soldati dell'ultima fila, per i quali era più facile vedere che sentire l'oratore, fraintesero le parole che credevano di interpretare attraverso i gesti e si sparse la voce che avesse promesso a ciascuno il diritto di portare l'anello e di possedere i quattrocentomila sesterzi.
CESARE CONTRO POMPEO( 34 ) Questo è l'ordine cronologico e il sunto delle imprese che compì in seguito: occupò il Piceno, l'Umbria e l'Etruria; accettata la resa di Lucio Domizio, che, in mezzo a una gran confusione, era stato nominato suo successore e teneva Corfinio con una guarnigione, lo lasciò libero di andarsene; seguendo la litoranea adriatica, si diresse verso Brindisi, dove si erano rifugiati i consoli e Pompeo per attraversare il mare al più presto.
Dopo aver cercato invano di impedire la loro partenza con tutti i mezzi possibili, ritornò verso Roma, dove illustrò ai senatori la situazione politica, quindi mosse verso le ben addestrate truppe di Pompeo che si trovavano in Spagna al comando di tre luogotenenti: M. Petreio, L. Afranio e M. Varrone.
Ai suoi amici, prima di partire, disse che andava contro un esercito senza comandanti e che poi si sarebbe mosso contro un comandante senza esercito. Quantunque l'assedio di Marsiglia, che durante il viaggio gli aveva chiuso le porte in faccia, e una pericolosa penuria di frumento gli imponessero dei ritardi, tuttavia in breve tempo sistemò ogni cosa.
![]() |
| CESARE VINCE A FARSALO |
UCCISIONE DI POMPEO E DI TOLOMEO( 35 ) Dalla Spagna tornò a Roma, quindi passò in Macedonia dove tenne assediato Pompeo con formidabili fortificazioni per circa quattro mesi, finché lo sconfisse nella battaglia di Farsalo. Pompeo fuggì e Cesare lo inseguì fino ad Alessandria, dove seppe che era stato ucciso.
Rendendosi conto che il re Tolomeo gli tendeva insidie, combatté anche contro di lui una delle guerre più difficili, in una posizione sfavorevole e in una stagione poco clemente, d'inverno, tra le mura di un nemico ben provvisto di rifornimenti e particolarmente ingegnoso, mentre lui era privo di tutto e assolutamente impreparato.
Uscitone vincitore, concesse il regno d'Egitto a Cleopatra e a suo fratello minore, temendo che, se lo avesse ridotto allo stato di provincia romana, divenisse un giorno, nelle mani di un governatore audace, un focolaio di rivoluzione.
Da Alessandria passò in Siria e di qui nel Ponto, dove lo chiamavano notizie pressanti di Farnace, il figlio del grande Mitridate, che aveva approfittato delle circostanze per entrare in guerra e che già si esaltava per i numerosi successi.
Meno di cinque giorni dopo il suo arrivo, quattro ore dopo il loro incontro, Cesare lo sconfisse in una sola battaglia; per questo faceva spesso allusione alla fortuna di Pompeo che aveva conquistato la maggior parte della sua gloria militare contro nemici così poco validi. In seguito sconfisse, in Africa, Scipione e Giuba, che tentavano di rianimare i resti del partito pompeiano, e, in Spagna, i figli di Pompeo.
LE UNICHE SCONFITTE SONO DEI GENERALI
( 36 ) Durante tutte queste guerre civili, Cesare non subì sconfitte se non per colpa dei suoi luogotenenti, dei quali Caio Curione morì in Africa, Caio Antonio cadde in mano dei nemici nell'Illirico, Publio Dolabella perse la flotta, sempre nell'Illirico, e Cneo Domizio Calvino ci rimise l'esercito nel Ponto.
Per quanto riguarda lui personalmente, si batté sempre vittoriosamente, e la situazione non fu mai incerta se non in due occasioni: la prima a Durazzo dove, respinto, disse che Pompeo non sapeva vincere perché aveva rinunciato ad inseguirlo; la seconda in Spagna, durante l'ultima battaglia quando, disperando ormai del successo, pensò perfino di darsi la morte.
I TRIONFI( 37 ) Concluse le guerre, riportò il trionfo cinque volte: quattro volte nello stesso mese, ma a qualche giorno di intervallo, dopo aver sconfitto Scipione, e una volta ancora, dopo aver superato i figli di Pompeo. Il primo, e il più bello, dei suoi trionfi fu quello Gallico, poi l'Alessandrino, quindi il Pontico, dopo l'Africano e infine lo Spagnolo, ciascuno differente per apparato e varietà di particolari.
Nel giorno del trionfo sui Galli, attraversando il Velabro, per poco non fu sbalzato dal carro a causa della rottura di un assale; salì poi sul Campidoglio alla luce delle fiaccole che quaranta elefanti, a destra e a sinistra, recavano sui candelieri.
Nel corso del trionfo Pontico, tra gli altri carri presenti nel corteo, fece portare davanti a sé un cartello con queste tre parole: «
Venni, vidi, vinsi», volendo indicare non tanto le imprese della guerra, come aveva fatto per le altre, quanto la rapidità con cui era stata conclusa.
SOLDI AI VETERANI E CIBO AL POPOLO( 38 ) Alle sue vecchie legioni, oltre ai duemila sesterzi che aveva promesso come preda a ciascun fante, all'inizio delle sommosse civili, ne diede anche altri ventiquattromila. Assegnò anche dei campi, ma non contigui, per non procedere ad espropri.
Quanto al popolo fece distribuire non soltanto dieci moggi di frumento e altrettante libbre d'olio, ma anche trecento sesterzi per persona, che un tempo aveva promesso, e ne aggiunse altri cento per farsi perdonare il ritardo.
Condonò inoltre, per un anno, gli affitti delle abitazioni che a Roma arrivavano fino a duemila sesterzi e in Italia fino a cinquecento. A queste liberalità aggiunse una distribuzione di pasti e di carne e, dopo la vittoria in Spagna, di due pranzi, perché la prima distribuzione gli era sembrata insufficiente e poco degna della sua generosità; quattro giorni dopo offrì un altro ricchissimo banchetto.
![]() |
| I TRIONFI |
SPETTACOLI DI GLADIATORI E NAUMACHIA( 39 ) Offrì spettacoli di vario genere: combattimenti di gladiatori, rappresentazioni teatrali, allestite in tutti i quartieri della città e per di più con attori che parlavano tutte le lingue, giochi ginnici nel circo e battaglie navali.
Ai combattimenti di gladiatori, allestiti nel foro, presero parte Furio Leptino, di famiglia pretoria, e Quinto Calpeno, un tempo senatore e avvocato. Ballarono la Pirrichia i figli delle più grandi famiglie dell'Asia e della Bitinia.
Alle rappresentazioni teatrali Decimo Laberio, cavaliere romano, propose un mimo di sua creazione, poi, dopo aver ricevuto in dono cinquecento sesterzi e un anello d'oro, abbandonò la scena e attraversò l'orchestra per andarsi a sedere su uno dei quattordici gradini.
Per i giochi del circo si ingrandì l'arena da una parte e dall'altra e vi si condusse intorno un fossato: i giovani della più alta nobiltà guidarono bighe, quadrighe e cavalli da corsa.
Una duplice schiera di fanciulli, differenti per età, realizzò il gioco troiano. Cinque giorni furono dedicati alla caccia e, alla fine tutto si risolse con una battagli a tra due schiere che comprendevano ciascuna cinquecento fanti, venti elefanti e trenta cavalieri. Per lasciare più spazio ai combattenti erano state tolte le mete e allestiti al loro posto due accampamenti opposti uno all'altro.
Alcuni atleti lottarono per tre giorni in uno stadio appositamente costruito per la circostanza nel quartiere del Campo di Marte. Per la battaglia navale si scavò nella piccola Codeta un bacino dove si scontrarono, con grande numero di combattenti, biremi, triremi e quadriremi, raggruppate in due flotte, una tiriana e l'altra egiziana.
Tutti questi spettacoli determinarono un tale afflusso di gente, venuta da ogni parte, che la maggioranza degli stranieri si sistemò sotto le tende erette nei vicoli e nelle strade, e molti furono schiacciati e uccisi dalla folla. Tra questi anche due senatori.
RIFORMA DEL CALENDARIO( 40 ) Dedicandosi quindi alla riorganizzazione dello Stato, Cesare riformò il calendario nel quale, per colpa dei pontefici che avevano abusato dei giorni da intercalare, si era determinato un tale disordine che le feste della mietitura non cadevano più in estate e quelle della vendemmia in autunno.
Regolò allora l'anno secondo il corso del sole, in modo che vi fossero trecentosessantacinque giorni e, eliminato il mese da intercalare, stabilì che si aggiungesse un giorno ogni quattro anni. Ma, perché da allora in poi fosse più sicura la concordanza delle date, a partire dalle successive calende di gennaio, aggiunse altri due mesi tra quelli di novembre e dicembre. Così quell'anno, in cui fece la riforma, fu di quindici mesi, perché, secondo l'usanza, proprio allora era il turno del mese da intercalare.